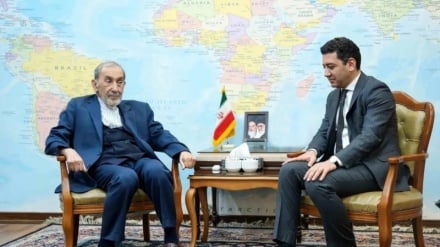Analisi del conflitto Armenia-Azerbaijan
- Il territorio montuoso del Nagorno-Karabach è entrato a far parte dell’Azerbaigian nel 1921 per decisione dell’Ufficio Caucaso del Partito Comunista Russo.
In precedenza, l’enclave –abitata da armeni sin dai tempi dell’Impero Romano – era parte di uno dei governatorati dell’Impero russo, dove, all’inizio del XX secolo, si sono verificati sanguinosi scontri tra gli abitanti armeni e azeri del territorio per motivi religiosi. Gli armeni sono infatti cristiani, con una chiesa autonoma, la Chiesa apostolica armena, mentre gli azeri sono musulmani sciiti.
La cessione del territorio all’Azerbaigian da parte delle nuove autorità comuniste ha sempre destato il disagio della popolazione armena, che, secondo i censimenti di epoca sovietica, era la maggioranza.
Nel 1988, durante il processo della “perestrojka”, l’allora autonomia azera popolata per lo più da armeni annunciò il desiderio di separarsi dall’Azerbaigian per entrare in Armenia. Tale decisione fu accompagnata da sanguinosi scontri dentro e fuori il Nagorno-Karabach. A Baku e a Sumgait, in Azerbaigian, si verificarono veri e propri pogrom contro la popolazione di etnia armena, almeno 200 persone furono uccise. Tra il 1989 e il 1993, oltre 200.000 armeni hanno lasciato l’Azerbaigian. Gli abitanti azeri del Karabach, 37.000 persone secondo l’ultimo censimento sovietico, furono costretti ad abbandonare la regione.
La guerra del 1991-94
Le tendenze nazionaliste in Azerbaijan e Armenia continuarono a crescere e nel 1991, subito dopo lo scioglimento dell’Unione Sovietica, scoppiò una sanguinosa guerra per il controllo del Nagorno-Karabach tra le due repubbliche.
Gli scontri armati sono durati tre anni e hanno causato circa 25.000 morti. Come conseguenza del conflitto, l’Azerbaigian ha perso il controllo del Nagorno-Karabach e di sette distretti adiacenti, occupati dalla parte armena, che li considera una “striscia di sicurezza”.
Durante la guerra, nel 1992, si tenne in Karabach un referendum, durante il quale la quasi totalità della popolazione si espresse a favore della proclamazione del territorio separatista come repubblica indipendente. Il territorio assunse il nome di Repubblica di Artzakh.
Tuttavia, l’entità autoproclamata non è stata finora riconosciuta da alcun membro della comunità internazionale, compresa l’Armenia. Il premier armeno Pashinyan, alla luce del conflitto attuale, ha affermato che Erevan potrebbe riconoscere la Repubblica di Artzakh.
La tregua del 1994
Le sconfitte militari provocarono la caduta dei primi due presidenti dell’Azerbaigian indipendente, Ayaz Mutallibov e Abdulfaz Elcibey. Nel 1994, quando salì al potere Heydar Aliyev, padre dell’attuale presidente azero Ilham, fu firmata una tregua tra le tre parti in conflitto – Azerbaigian, Armenia e Nagorno Karabach, nell’ambito di una cerimonia che si è svolta nella capitale del Kirghizistan, Bishkek, sotto gli auspici della Russia.
Contemporaneamente, in seno all’Organizzazione per la Sicurezza e la Cooperazione in Europa (OSCE) è stato creato il Gruppo di Minsk per la soluzione pacifica del conflitto in Karabach, copresieduto da Russia, Francia e Stati Uniti. Il Gruppo di Minsk per 16 anni ha cercato di portare i negoziati fuori da un punto morto senza grandi successi.
Secondo l’Armenia, uno dei motivi dello stallo è che il Nagorno-Karabach è stato escluso dal processo negoziale, poco dopo la firma del cessate il fuoco.
Da parte sua, l’Azerbaigian insiste sul fatto che la soluzione al conflitto implica necessariamente la liberazione dei territori occupati, richiesta che è stata sostenuta da diverse risoluzioni del Consiglio di sicurezza dell’ONU.
La guerra dei quattro giorni del 2016
Da quando il conflitto è stato “congelato” lungo una linea del cessate il fuoco per la quale l’Azerbaigian ha perso un quinto del territorio che aveva ai tempi sovietici, più di una volta si sono verificati scontri tra l’esercito locale, appoggiato dall’Armenia e le truppe azere.
L’ultimo scontro, prima di quello in corso, che aveva riacceso i timori di un conflitto su vasta scala si è svolto nell’aprile 2016 ed è stato chiamato la “guerra dei quattro giorni”.
Durante quell’escalation, almeno trecento persone sono state uccise da entrambe le parti e diverse centinaia sono rimaste ferite.
Negli ultimi anni si sono registrati scontri tra i due Paesi non solo nell’area del Nagorno-Karabach, ma anche al confine di stato tra Armenia e Azerbaigian.
L’ultimo di questi scontri ha avuto luogo nella zona settentrionale del confine comune il 12 luglio scorso, nella regione di Tavush, e continua ancora oggi.
Le parti impiegano non solo armi leggere ma anche artiglieria pesante e aviazione.
Ufficialmente, questi scontri, già condannati dalla comunità internazionale, hanno causato almeno venti morti da entrambe le parti, tra cui numerosi civili.
Le due parti si accusano vicendevolmente di aver dato inizio agli scontri tentando un’invasione.
Gli scontri in corso
Domenica 27 settembre il conflitto è ripreso con un intenso bombardamento azero sulla periferia della capitale del Nagorno-Karabach, Stepanakert. L’Armenia e il Nagorno-Karabach hanno dichiarato la legge marziale e proclamato la mobilitazione generale. Anche l’Azerbaigian ha proclamato la legge marziale, ma la mobilitazione è parziale.
Baku e Erevan si accusano reciprocamente di aver iniziato il conflitto. Il bombardamento di Stepanakert, affermano le autorità azere, è stato la risposta a un attacco armeno lungo la linea del cessate il fuoco. “Una menzogna” – secondo il governo armeno.
Gli scontri si registrano da allora lungo tutta la linea del cessate il fuoco, in particolare nel saliente meridionale, nel dipartimento di Fizuli, una città azera conquistata dagli armeni nel 1993 e oggi parte della Repubblica di Artzakh.
Al momento si registrano circa 100 morti, di cui 84 soldati dell’esercito del Karabach.
segue
Potete seguirci sui seguenti Social Media:
Instagram: @parstodayitaliano
Whatsapp: +9809035065504, gruppo Notizie scelte
Twitter: RadioItaliaIRIB
Youtube: Redazione italiana
VK: Redazione-Italiana Irib
E il sito: Urmedium