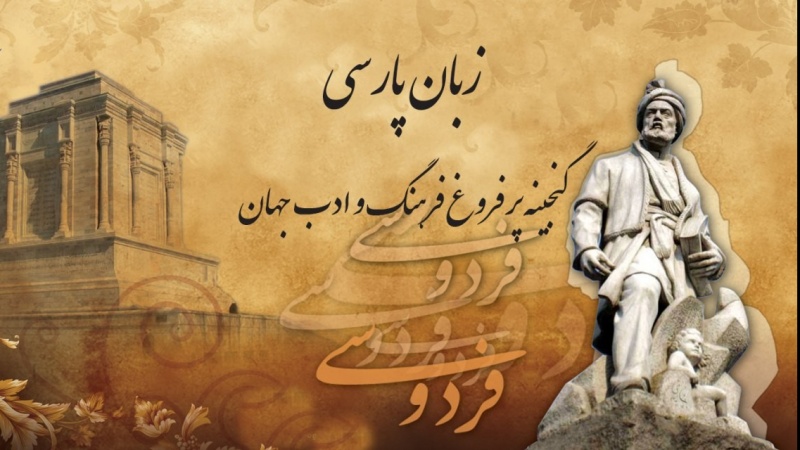Iraniani Famosi (35): Letteratura persiana neo-classica p.2
Oggi il nostro discorso e’ incentrato ancora una volta sulla letteratura persiana neo-classica.
Il primo perido in cui si è soliti suddividere le tappe fondamentali della letteratura persiano è compreso tra il V sec. a.C. e la conquista araba del 651 d.C.; il secondo dal 651 fino ai giorni nostri.
Appartengono al primo periodo solo due categorie di documenti: le iscrizioni monumentali in antico persiano e i testi religiosi zoroastriani. Le iscrizioni, in caratteri cuneiformi scolpiti su roccia o su tavolette, magnificano le opere e le gesta dei Gran Re achemenidi da Ciro il Vecchio ad Artaserse III (sec. VI-IV a.C.) e hanno valore più documentario che artistico.
I testi religiosi sostanzialmente si identificano con l’Avesta, libro sacro dei seguaci di Zarathustra, in lingua avestica, che raccoglie preghiere, prediche sacre, inni, brevi opere liturgiche, rituali e norme giuridiche.
All'età sasanide appartiene la produzione in medio-persiano o pahlavico, per la massima parte di argomento religioso zoroastriano: traduzioni e commenti dell'Avesta e opere originali come il Denkart e il Bundahishn, specie di enciclopedie del sapere teologico dell’epoca (III-VII sec. d.C.). Scarsa è anche la produzione letteraria profana salvata nei secoli, ma in compenso molto interessante per la varietà degli argomenti e per le notizie che fornisce sulle tradizioni della Persia pre-islamica, come un ampio frammento di codice sociale che ci informa circa il diritto privato nell’epoca sasanide, un manuale epistolare, un glossario, una fantasiosa “Storia degli scacchi” e due racconti anonimi che hanno per tema leggende analoghe a quelle di Ferdousi nel Libro dei Re.
Le prime manifestazioni letterarie dell'Iran islamico risalgono al sec. IX, nella lirica cortigiana fiorita sotto i Tahiridi, i Saffaridi ed i Samanidi, le prime dinastie autonome sorte in margine al califfato. Specialmente sotto i Samanidi, che regnano nel Khorasan dalla fine del sec. IX a tutto il X, la vita culturale iraniana rifiorisce intensa e una pleiade di poeti aulici (Rudaghi, Daqiqi, ecc.) solleva ad alto livello d'arte e di stile la lingua nazionale.
Con l’ingresso nella civiltà islamica, la letteratura persiana conosce una straordinaria fioritura. I primi due secoli dopo la conquista araba si definiscono di transizione, durante i quali si forma una nuova lingua, il neopersiano, derivato dalla fusione della lingua parlata con l’arabo e dall’apporto di molteplici tradizioni letterarie precedenti. La produzione letteraria del periodo è cortigiana e colta; si sviluppano la lirica laudatoria, la poesia epico-romanzesca e mistico-didattica, la prosa storica e d’arte.
Durante la dinastia Samanide (874-1004), che regna nel Khorasan, la vita culturale è intensa; una pleiade di poeti aulici (Rudaghi, Daqiqi, Kisai) porta ad alto livello d'arte e di stile la lingua nazionale, tanto che il persiano moderno diventa lingua dell’amministrazione e della cultura.
La dinastia dei Ghaznavidi (962-1186) raduna attorno a sè i migliori ingegni dell’epoca con i maggiori poeti persiani, tra cui Ferdousi (940-1020 ca), autore dello Shahnamah (Libro dei Re) che raccoglie antiche leggende eroiche dell’Iran. Mettendo in versi le tradizioni epiche nazionali, congiungendo una profonda religiosità a un ardente patriottismo, Ferdousi crea un’opera grandiosa (ben 50.000 versi doppi) e dona alla sua patria il poema nazionale per eccellenza.
Nella seconda metà dell’XI sec. fioriscono soprattutto la prosa e la poesia mistica. Fra i colti visir della dinastia selgiuchide, Nizam ul-Mulk descrive i movimenti politico-religiosi diramatisi dallo sciismo (Ismailiti, Qarmati, Drusi, Assassini); i mistici attenuano le rigidità del Corano con le dottrine del “sufismo” panteistico, di lontana origine neo-platonica.