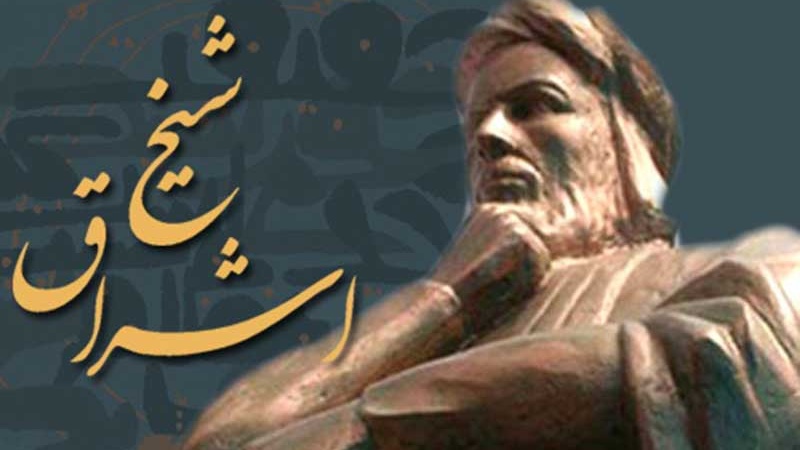Iraniani Famosi (63): Sohravardì (p.5)
Anche oggi si parla di uno dei più grandi filosofi della storia umana, ovvero Sohravardì.
Gentili ascoltatori, nel corso delle puntate precedenti vi abbiamo parlato dei dati biografici di Sohravardì, il grande filosofo e mistico persiano del 12esimo secolo che fu l’ideatore dell’Ishraq, una teoria filosofica che basandosi sull’Islam e la tradizione platonica e persiana pre-islamica, insegna come scoprire e come avvicinarsi alla verità.
Shoravardì nacque nel 549 dell’egira e si spense nel 587, all’età di 38 anni con la congiura dei capi religiosi di Aleppo che strapparono a Saladino l’ordine della sua esecuzione.
Abbiamo detto che l’esito della breve ma generosa vita di Sohravardì furono numerose opere, trattati e parabole che secondo i ricercatori ci mostrano il vero pensiero di questo filosofo. L’uso abbondante di parabole e racconti da parte di Sohravardì influenzò notevolmente anche la letteratura persiana ed ispirò grandi che passarono alla storia come Attar, Rumì e Hafez.
***
Una delle opere in persiano di Shahabeddin Sohravardì e’ il saggio “Fi Haghighat-el-Eshq” (Sulla verità dell’amore), anch’esso in linguaggio simbolico. L’asse del libero e’ la storia di Giuseppe d’Egitto e della moglie del Faraone che s’innamora di lui ma Shoravardì, usando una serie di termini in codice, nelle sue poesie, cerca di esprimere i suoi pensieri filosofici.
In tante opere Sohravardì, parla della lontananza, del dolore dell’uomo per la solitudine in questa vita terrena, ma in quest’opera l’argomento principale e’ l’amore; secondo Sohravardì l’amore ha due fratelli: Hosn (la bellezza) e Hozn (la tristezza).
Secondo alcuni esperti, il saggio Fi Haghighat-e-Eshq e’ una interpretazione romantica della sura di Giuseppe del Corano.
Sohravardì nella sua opera spiega che inizialmente Dio creò la ragione. In seguito diede alla ragione tre capacità: per prima cosa la conoscenza di Dio, poi la conoscenza dell’uomo stesso ed alla fine la conoscenza del prossimo. La prima capacità della ragione creò la bellezza, la seconda creò l’amore e la terza la tristezza. Con una metafora filosofica, Sohravardì scrive che la bellezza rimase entusiasta della sua apparenza e così dal suo sorriso nacquero gli angeli. Dalla passione tra l’amore e la bellezza si vennero a creare i cieli e la terra.
La creazione del mondo, come viene raccontata in maniera romantica da Sohravardì, proseguì con la creazione dell’uomo ad opera di Dio e così la bellezza andò a vedere l’uomo terreno per curiosità. La bellezza s’innamorò perdutamente dell’uomo e così tutta l’esistenza umana viene pervasa dall’amore. E così con il passare dei giorni, quando la bellezza rimase dall’uomo e non tornò a casa, i suoi fratelli, l’amore e la tristezza si misero alla sua ricerca. Quando videro che la bellezza era entrata nel corpo dell’essere umano, anche i suoi fratelli, amore e tristezza, cercarono di entrare nel suo essere ma non fu possibile. E così l’amore, la tristezza e gli angeli caddero in ginocchio dinanzi all’imponenza dell’essere umano.
Dopo Adamo, la bellezza trovò dimora nell’essere di Giuseppe che venne buttato nel pozzo dai suoi fratelli. I fratelli della bellezza, scelsero ognuno una meta; la tristezza andò a Kanaan dal padre di Giuseppe, l’amore invece andò da Zoleikha, la moglie del Faraone d’Egitto.
Alla fine della storia, quando Giuseppe ritrova il padre e perdona i fratelli, anche i tre fratelli ovvero la bellezza, la tristezza e l’amore, si ritrovano.
Dopo questo racconto, Sohravardì dà una interpretazione della vicenda narrata ed esprime la sua visione del mondo attraverso l’amore, la bellezza e la tristezza.